Una domanda che mi sono sempre fatto riguarda il rapporto Bilardo-Maradona. Diego ha sempre amato, almeno nelle uscite pubbliche, gli allenatori con rivoluzionarie idee offensive. Poi però ha deciso di diventare un uomo di Bilardo. Tu hai capito come coesistevano nella sua testa le due cose?
Diego ha sempre amato gli allenatori che andavano a cercarlo dicendogli, in maniera più o meno esplicita, più o meno remissiva, «questo è lo scettro, questo è il mio regno, te lo cedo, fanne buon uso». E credo dipendesse, sostanzialmente, dal fatto che nessun sovrano sano di mente avrebbe avuto il coraggio di non abdicare a favore di uno come Diego. Il rapporto tra Diego e Bilardo, in fondo come l’avventura stessa di Bilardo alla guida dell’Albiceleste, è sorto dalla cenere: l’Argentina veniva dalla quasi disastrosa avventura di Spagna ‘82, Menotti – bisognerebbe poi approfondire l’aggettivazione rivoluzionario nel lessico del Flaco – aveva mollato e Bilardo si era trovato nel bel mezzo di un tornado nel quale aveva tutto tranne che certezze. E si era andato a cercare la pietra angolare proprio in Diego, in un momento non proprio brillante – cioè quando era fermo ai box, a Barcellona, per via dell’epatite. Lo aveva raggiunto nella convalescenza, alle sette del mattino gli aveva detto andiamo a farci una camminata e lì gli aveva detto che lo voleva capitano. Che avrebbe costruito l’Argentina su di lui. Che la Selección sarebbe stata «Maradona più altri dieci». Non credo che a Maradona sia mai interessata la filosofia del buon gioco di un allenatore: il buon gioco era lui.
A proposito di idee, ma in Argentina c’è ancora la faida fra due pensieri calcistici agli antipodi (menottisti vs bilardisti) o i concetti di gioco europei hanno annacquato almeno in parte lo scontro?
A essere sinceri, forse, non c’è mai stata: pensaci bene, alla fine della fiera ogni menottista è un po’ bilardista, e ogni bilardista un po’ menottista. Menotti non è che inseguisse l’arte per l’arte, il fine ultimo era anche per lui quello di vincere – e nel Mundial ‘78 anche lui ha sacrificato l’estetica sull’altare del pragmatismo: escludere Diego cosa è stata, se non una scelta massimamente pragmatica? Alla stessa maniera, non è che Bilardo rifiutasse categoricamente il bel gioco. Certo, negli anni Ottanta la contrapposizione era più netta perché si trattava di raccogliere eredità, continuare a scrivere la storia: Menotti era più tradizionalista di quanto possiamo immaginare, la sua rivoluzionarietà è tutta nelle modalità in cui perseguiva i risultati, mica nelle idee (il suo ideale era il calcio che si giocava a inizio novecento!). E Bilardo, beh, Bilardo non sarebbe mai potuto essere Zubeldía perché, banalmente, Zubeldía i giocatori che ha guidato Bilardo se li sognava. Gli allenatori argentini successivi a questa presunta contrapposizione, più che inscriversi in un solco, credo siano stati bravi a sufficienza da assorbire entrambe le filosofie: Bielsa, Sampaoli, Gallardo, Sabella, sono tutti stati un po’ l’uno, un po’ l’altro. Personalmente credo che a far saltare il banco, in fondo, sia sempre la presenza del fenomeno generazionale: Scaloni come dovremmo definirlo? Menottista o Bilardista? Per me, come gli altri citati prima, è entrambi. Ma per buona parte della sua parabola ha potuto contare sul miglior Messi in Albiceleste, e non credo che il ridimensionamento della filosofia tecnica non sia in diretta connessione con presenze così abbacinanti.
Quali difficoltà e quali godimenti hai vissuto nella traduzione di questo libro?
Ogni traduzione si porta dietro oneri e onori: l’onore è quello di vederti consegnare le chiavi per entrare nel cervello dell’autore. L’onere è quello di dover restituire, in un’altra lingua, nella miglior maniera possibile, con la fluidità e l’estetica proprie della lingua di partenza, i suoi ragionamenti. Burgo, in questo libro, ci regala una serie di aneddoti, di punti di vista, di connessioni necessarie per comprendere cosa abbia significato, per gli argentini, quella partita. Non so se l’immagine regge, ma mi sono sentito un po’ come l’atleta al quale la delegazione olimpica consegna la bandiera per sfilare davanti a tutti nel corteo. Stargli dietro, verificare la veridicità delle versioni, schivare le contraddizioni e i malintesi, forse, è stata la parte più dura: mi sono sentito come il centrocampista con compiti di arginamento e raccordo del gioco incaricato di marcare il fantasista, ma non per impedirgli di fare le sue giocate: per accondiscenderlo.
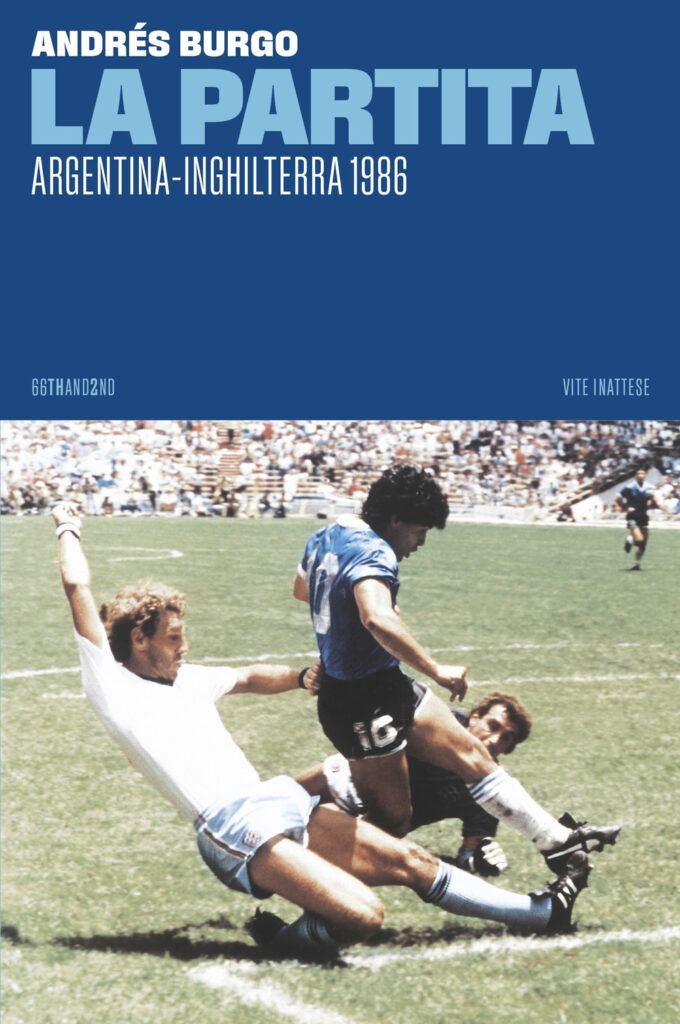
Le parole non tradotte sono poche rispetto a quelle che, credo, potevano restare nel testo. Ė una scelta che hai fatto per rendere più facilmente comprensibile il testo o per dare risalto a quelle poche parole che restano come nell’originale?
Qui tocchi un argomento sensibile: la norma principale, che è anche una norma di buon senso, è quella di lasciare una parola nella lingua originale non tanto quando è intraducibile – ammesso che esistano parole intraducibili – ma quando la traduzione snatura, o peggio deflora, il termine di partenza. Il calcio argentino ha così permeato il nostro discorso calcistico che potremmo tranquillamente attingere da quell’apparato lessicografico senza incorrere nel rischio della mancata comprensione: per intenderci, è probabile che il lettore de La Partita sia un lettore mediamente edotto su cosa significhi gambeta. Non ho compiuto, scientemente, una scelta tra quelle che suggerisci – nonostante mi renda conto, ora che ne parliamo, che forse i punti di arrivo sottesi erano proprio entrambi questi, cioè salvaguardare la comprensibilità e allo stesso tempo dare risalto alle poche non tradotte, perché davvero fondamentali.
In generale, non sono un amante dell’oriundizzazione della lingua a meno che non risponda a precise necessità funzionali di tipo conativo o poetico, per dirla à la Jakobson.
Un triello che non riesco a capire bene è quello fra Maradona, Bilardo e Passarella. Portano il vecchio capitano per assistere in silenzio all’ascesa del nuovo, con l’allenatore che lo sopporta a stento anche se in parte lo ammira e il Diez che lo usa come un motivatore interno alla squadra. Con la questione dell’intossicazione alimentare alla fine è andata liscia, ma poteva finire malissimo.
Tu c’hai capito qualcosa?
Ovviamente no: forse l’unico che c’ha capito davvero qualcosa è proprio Passarella, che però si guarda bene dal raccontarlo – nonostante lasci intendere di avere certezza di essere stato al centro di un complotto.
La situazione di partenza, in fondo, non è poi così strana: Passarella aveva alzato la Coppa del Mondo nel ‘78, era stato uno dei giocatori più brillanti delle ultime gare di qualificazione, come fai a non portarlo? Allo stesso modo, l’ascesa di Diego, all’interno di quel gruppo, sebbene tutt’altro che scontata, era decisamente scritta. Come avrebbe gestito le acredini, Bilardo, cioè l’uomo che da giocatore aveva visto il suo tecnico Zubeldía tirare un sasso su un vetro dell’hotel di Manchester in cui il suo Estudiantes riposava alla vigilia della gara di Intercontinentale per poi chiamare polizia e giornalisti per lamentarsi dell’accaduto, ma anche l’uomo che – da allenatore dell’Albiceleste – ha tirato giù la bandiera argentina dal pennone di Trigoria, l’ha lacerata, l’ha nuovamente issata e ha chiamato polizia e giornalisti per lamentarsi dell’accaduto: come avrebbe fatto, senza l’intossicazione alimentare? Ammesso che l’intossicazione non sia il sasso, o la bandiera lacerata, chi lo sa.
La Mano de Dios è diventata ormai archeologia oppure muove ancora gli animi e sottende quindi una questione morale (sia per gli inglesi che per gli argentini)?
Niente di ciò che a che fare con Maradona potrà mai essere considerato archeologia, perché è semplicemente trasceso già nel mito. Muove gli animi? Certo che li muove: è lo strumento di rivendicazione identitaria più potente che abbiano mai avuto, e che avranno ancora a lungo, gli argentini; e per gli inglesi è ancora l’epitome della più signorile, elegante, pregevole umiliazione che abbiano subito – su un campo di gioco, quantomeno –, raccolta però con il proverbiale sense of humour: sai come si chiama il club all’interno del quale, nell’Ambasciata Inglese a Buenos Aires, si possono vedere partite bevendo birra? Sì: si chiama Hand of God.
Ma credo che muova ancora gli animi, e sia fonte di ispirazione, un po’ come Il “Quarto stato” di Pellizza da Volpedo e “La liberté guidant le peuple” di Delacroix, soprattutto oltre gli argentini, oltre gli inglesi: si sia, cioè, cristallizzato in quella forma che assumono i miti quando diventano universali. Che è forse la più grande testimonianza di efficacia, di iconicità.
Una parte meravigliosa del libro riguarda la ricostruzione semantica del “barrilete cosmico” di Victor Hugo Morales. Oggi in Argentina quella parola (barrilete) che sensi ha acquisito?
Mah, ha acquisito i significati che ha sempre avuto: se ti dicono sos un barrilete non è che ti stiano propriamente facendo un complimento, il range di significati va da «sei una banderuola» a «sei uno che cambia completamente idea da un momento all’altro» – anche se, come diceva Julio Cortázar, «solo l’imbecille non cambia idea tre volte al giorno». Però, poi, finisce sempre per spuntare un sorriso, in punta di sillabe, perché ci sono certe parole che diventano capsule del tempo, e tra i pertugi delle consonanti arcuate, delle anse delle vocali, si incancreniscono i ricordi, i rimandi.
Si parla ancora della “Nuca de Dios” di Olarticoechea (altro, anzi forse il vero miracolo) o è scomparsa dai radar?
Quando nel 2016 Gerardo Martino ha rassegnato le sue dimissioni da allenatore dell’Albiceleste, l’AFA ha scelto di affidare la Selección a Edgardo Bauza e la Nazionale Olimpica, attesa al torneo in Brasile, al Vasco Olarticoechea. Olarticoechea non aveva alcuna esperienza pregressa da tecnico (se si esclude un anno alla guida della nazionale femminile), la sua era più un’investitura honoris causa (a trent’anni dal Mundial messicano, vieppiù), ma quella volta, semplicemente, non ci furono miracoli e quindi non andò bene: l’Argentina venne eliminata al primo turno ma nonostante questo, al suo ritorno a Saladillo, città nel cono bonaerense in cui è nato e in cui vive oggi, la copiosa comunità basca gli ha dedicato un monumento, bruttino per dirla tutta, una specie di fantasma a righe albiceleste con il numero 16 ben in vista. Non sono molte le persone a cui una comunità dedica un monumento mentre è ancora in vita (per quanto orrendo): Bell Ville l’ha fatto con Kempes, Saladillo con Olarticoechea. Oggi nessuno se lo ricorda più, el Vasco, tranne te che me lo chiedi, e io che ti sto rispondendo. Ma a lui sembra importargliene il giusto: gira per Saladillo, si ferma a salutare, torna a casa con le buste della spesa. Un refolo di vento gli scompiglia i pochi capelli che gli sono rimasti sulla nuca, lui sorride. Chissà se nessuno penserà mai di girare un film e di intitolarlo «È stata la nuca di Dio». Sarebbe bello.
